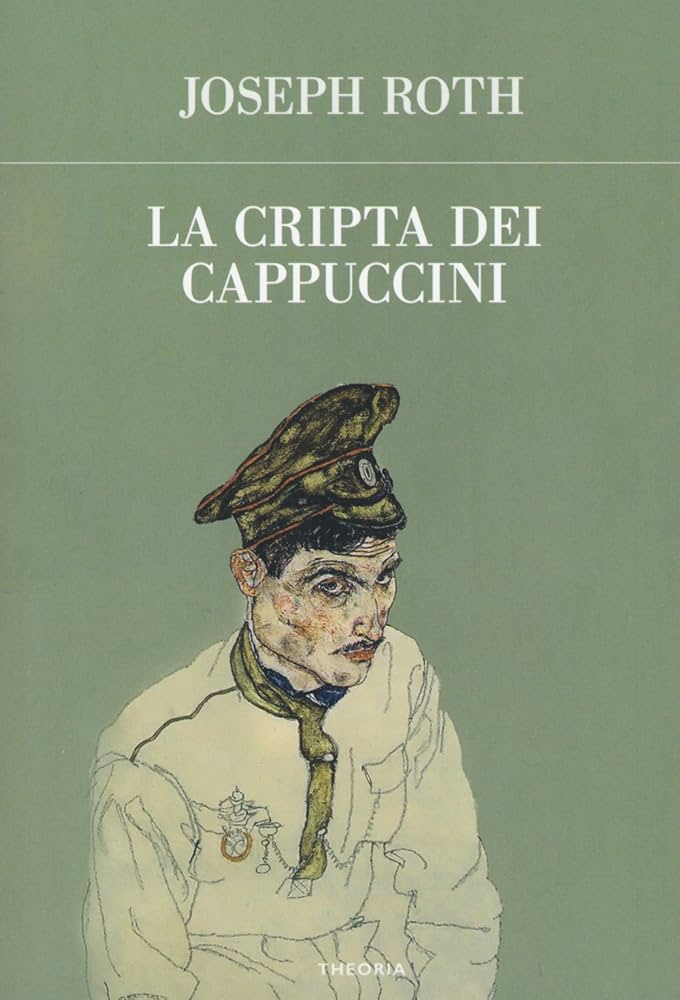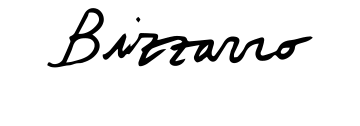Joseph Roth racconta la fine di un mondo attraverso la parabola interiore di un uomo smarrito. Ambientato alla vigilia e durante la Prima Guerra Mondiale, La cripta dei Cappuccini è il ritratto di una generazione sospesa, stretta tra il culto dell’onore e il desiderio di una vita domestica, tra l’impulso alla fuga e l’impossibilità di scegliere davvero. Un romanzo che scava nel conflitto tra sentimento e dovere, tra paura e silenzio, fino a mostrare il vuoto lasciato dalla disillusione.
Una generazione sospesa tra dovere, desiderio e disillusione Nel 1913, il cugino Trotta eredita dal padre defunto una cospicua somma di fiorini, alcuni dei quali sarebbero stati destinati al matrimonio della propria sorella con il più ricco contadino di Sipolje. La restante parte dell’eredità sarebbe stata utilizzata per ingrandire i suoi affari. Francesco Ferdinando, che amava la sorella di Kovacs, Elisabeth, considerava l’amore come una debolezza, un’aberrazione. Nonostante questo, amava Elisabeth in segreto, temendo che una dichiarazione d’amore potesse tradire la fiducia di tutti, in particolare quella degli amici e della madre. Provava vergogna verso se stesso, verso gli altri e soprattutto verso sua madre, la quale vedeva come una macchina incubatrice.
Francesco Ferdinando incontrò Manes Reisiger, un ebreo proveniente dalla Galizia, che desiderava un posto per il figlio Ephraim, musicista di talento. Dopo averlo aiutato, Ephraim fu accolto al conservatorio viennese.
Nonostante fosse miscredente e non andasse mai in chiesa, Francesco Ferdinando era influenzato dal pensiero dei suoi amici, che rifiutavano la tradizione religiosa, vivendo in un’atmosfera di ribellione e puerilità. Non sentiva la morte, non sentiva Dio, e si considerava semi anarchico.
Nel 1914, la guerra sembrava arrivare al momento giusto. Francesco Ferdinando era spaventato dalla morte, ma il pensiero di Elisabeth e dei suoi amici svanirono quando si trovò faccia a faccia con il pericolo della guerra. La sua vita sembrava ormai un bivio tra la morte e l’amore. Nonostante le sue paure, si sentiva coraggioso e decise di sposare Elisabeth, partendo poi per il fronte.
Nel campo di battaglia, ogni soldato aveva fissato delle nozze, ma la guerra, che pareva quasi un onore, sopprimeva ogni istinto di procreare. La vita diventava qualcosa di effimero, la morte era dietro l’angolo, e l’onore diventava l’unico narcotico che leniva la paura. La speranza di un ritorno alla vita domestica e di una vecchiaia tranquilla con figli veniva messa alla prova.
Dopo il matrimonio con Elisabeth, che avvenne proprio il giorno in cui partiva per la guerra, Francesco Ferdinando fu catturato dal nemico a Krasne. Nel 1915, riuscirono a fuggire, iniziando una nuova vita in Siberia, ma dopo un litigio furono costretti a andarsene.
Nel 1918, tornò a Vienna, ma la sua vita era completamente cambiata. Trovò sua madre senza denaro e senza casa, e scoprì che Elisabeth aveva trasformato la sua vita in un’impresa artigianale, diventando una donna d’affari. Quando si incontrò con Elisabeth, non la considerò più sua moglie, ma solo una “cosa-oggetto”, la cui esistenza era ormai estranea alla sua vita.
Dopo il funerale della madre, Francesco Ferdinando si rese conto che aveva perso tutto: la famiglia, gli amici, la casa e la dignità. La guerra gli aveva tolto ogni speranza, lasciandolo vuoto, senza un futuro. La sua vita era ormai segnata dalla solitudine.
Il silenzio che resta dopo l’amore, la guerra e la perdita
Il romanzo La cripta dei Cappuccini è ambientato nel periodo della Prima Guerra Mondiale e racconta le lotte interiori di un uomo diviso tra il dovere e l’amore. In un contesto in cui i sentimenti sono considerati una debolezza, l’amore è vissuto come un’aberrazione, una malattia incurabile. La paura della morte, la vergogna verso i propri sentimenti e il conflitto tra il dovere verso la patria e l’amore per una donna sono temi centrali. L’autore descrive una generazione che, cresciuta nel culto dell’onore e della guerra, perde ogni senso di vita domestica e affettiva.
Le frasi del romanzo, come “giudicati inabili alla morte”, che sembrano una beffa per incoraggiare i soldati, e “Riposavano sotto terra i caduti in guerra, e la primavera ventura dalle loro ossa sarebbero nate le violette”, evocano un’immagine potente della morte e della speranza perduta.
La frase finale, “Dove devo andare ora io?”, esprime il vuoto e la solitudine di un uomo che ha perso tutto. Dopo la guerra, quando ha perso gli amici, la famiglia, la casa e la speranza, Francesco Ferdinando è spaesato. La sua vita, segnata dalla guerra e dall’abbandono, non ha più un senso. Questo sentimento di vuoto e disperazione è il vero dolore della vita, una realtà che distrugge giorno dopo giorno.